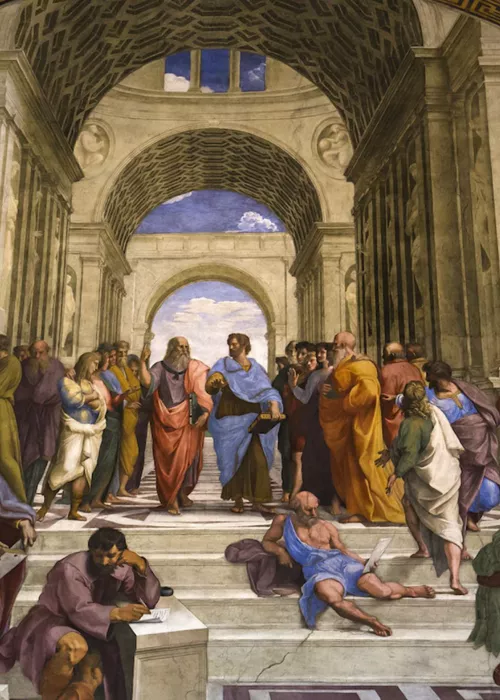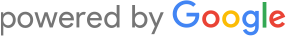Le vie del metallo. Relitti con carichi speciali sul fondo del mare
5 minuti

Anche se chi pensa ad antichi relitti ha spesso in mente l’immagine di grandi carichi di anfore, sul mare viaggiava un po’ di tutto: olio, vino, salse di pesce, ma anche pietre, metalli, schiavi, animali, pelli, oggetti di pregio. Non tutte queste merci si conservano per secoli sui fondali; alcune, però, hanno capacità di resistenza notevoli: i metalli, ad esempio, resistono molto a lungo nel sito degli antichi naufragi.
Corrosione, ossidazione e altre reazioni chimico-fisiche alterano lingotti e spiedi metallici, ma spesso attraverso trattamenti specifici di laboratorio è possibile riportare i metalli, o le leghe, alle loro forme originarie. Inoltre, analisi più raffinate possono ricondurre i metalli fino alle miniere da cui sono stati estratti i minerali: un aiuto importante per chi da un relitto intenda ricostruire una rotta o una relazione marittima.
Il metallo non è sempre il carico principale di un’imbarcazione: a volte il metallo viaggia accanto ad altri carichi, come mercanzia secondaria. Altre volte un piccolo quantitativo di metallo è imbarcato per il consumo e la vita di bordo: è il caso di alcuni relitti che hanno restituito uno o due lingotti di piombo, utilizzati per le piccole riparazioni.
Immergersi su carichi metallici è possibile, anche se non semplice: i relitti di questo tipo sono meno numerosi, e i progetti di fruizione sono ancora agli inizi. Le AMP italiane possono comunque contare su alcuni siti di particolare interesse e bellezza.
Anche per i metalli, come per le anfore, vale il principio della conservazione in situ come approccio prioritario: fatti salvi i campioni che, come detto, possono offrire dati preziosi soltanto attraverso analisi di laboratorio, i cumuli di spiedi e barre, le cataste di lingotti, i pani di rame possono resistere ancora per molti secoli sul fondo del mare, e trasformarsi in luoghi estremamente suggestivi.
Il relitto dei metalli di Capo Testa B

All’imboccatura occidentale delle Bocche di Bonifacio, nel punto in cui le navi provenienti dalla Penisola Iberica si preparavano a varcare lo stretto e sfidarne i pericoli per puntare in maniera diretta verso i grandi porti del Tirreno, un relitto ha offerto materiali metallici di grande interesse: è il relitto di Capo Testa B, nell’AMP omonima, non lontano da Santa Teresa di Gallura.
Individuato a 28 metri di profondità nel 1977 da un sub, poi indagato subito dopo dagli archeologi del centro di Albenga, il relitto trasportava un carico di metalli, composto da un gran numero di barre di ferro, sparpagliate sul fondale e poi unite in una grande concrezione, accompagnato da alcuni lingotti di piombo: questi ultimi presentavano delle iscrizioni con i nomi dei produttori, Caius Utius Caii filius e Cnaeus Atellius Cnaei libertus Bulio: due personaggi già noti agli studiosi, provenienti da famiglie di origine campana trasferitesi nella città di Carthago Nova, oggi Cartagena in Spagna, per sfruttarne le ricche miniere.
Molto interessante fu anche il rinvenimento di parte della nave, di una macina utilizzata a bordo, e di un elmo, a testimonianza della presenza di una piccola scorta armata per il trasporto.
Mal di Ventre: mille lingotti di piombo per Roma
In prossimità dell’isolotto di Mal di Ventre, sulla costa occidentale della Sardegna, nell’AMP della Penisola del Sinis, fu rinvenuto, a circa 30 metri di profondità, uno dei carichi più impressionanti del mondo antico. La nave di Mal di Ventre, scoperta nel 1988 da un subacqueo sportivo, trasportava infatti un carico, finora senza confronti, di oltre 1000 lingotti di piombo, prodotti nel I secolo a.C. nelle ricche miniere di Carthago Nova nella Penisola Iberica e bollati da un nugolo di produttori, perlopiù di origine campana.
Lo scavo del relitto fu una vera impresa, finanziata e supportata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso: il piombo antico, rimasto per venti secoli sul fondo del mare, non è solo una preziosa fonte di informazioni storiche e archeologiche ma anche una straordinaria risorsa per gli esperimenti più avanzati condotti dai fisici sulle particelle subatomiche; nel suo lungo riposo sui fondali, infatti, il piombo antico è rimasto al riparo dalle radiazioni atmosferiche, e si presta in maniera eccellente alla realizzazione di schermature per i laboratori del futuro.
Avere un’idea del carico di Mal di Ventre non è un sogno riservato ai sub: una selezione importante di oggetti recuperati dalla nave, compresi i lingotti di piombo, è esposta presso lo straordinario Museo di Cabras, affacciato sulla laguna omonima, a qualche chilometro da Tharros.
In acque bassissime. Il relitto di Cala Rossano a Ventotene

A Cala Rossano, uno dei punti più belli della splendida isola tufacea di Ventotene, persa nel blu tra Lazio e Campania, uno scavo condotto a partire dal 1990 ha permesso di documentare un relitto particolare.
La nave romana di Cala Rossano, spiaggiata a poco più di 3 metri di profondità, trasportava infatti un carico misto di anfore e metallo. Da una parte, le anfore di varie tipologie hanno offerto dati incredibili: iscrizioni dipinte con riferimento a produttori e prodotti hanno permesso di confermare, insieme ai resti di pece e ai reperti organici la presenza di salse di pesce, garum di sgombo, salse invecchiate, prodotti compositi con grappoli d’uva e vini passiti. Dall’altra, lingotti di stagno, ugualmente bollati dai produttori, sono stati ricondotti alle miniere di provenienza.
La nave di Cala Rossano aveva caricato materiali di varia natura ma di provenienza simile: tutto sembra prodotto infatti nella Penisola Iberica. Quasi arrivata a destinazione, evidentemente, la nave naufragò a poche miglia dalle coste tirreniche, forse tentando di sfuggire al mare grosso rifugiandosi in una cala di Ventotene, ma inutilmente.
Il relitto di Punta dell’Arco a Ventotene, profondo ma saccheggiato

A Punta dell’Arco, una delle estremità dell’isola di Ventotene, subacquei sportivi segnalarono un relitto romano a 42 metri di profondità. Pur non trovandosi in acque basse, il sito fu saccheggiato, ma una parte dei materiali, recuperata e custodita oggi presso il bel Museo Civico di Ventotene, ha permesso comunque di ricostruire molte informazioni.
La nave romana di Punta dell’Arco, naufragata intorno a Ventotene alla metà del I secolo a.C. trasportava un carico misto di vino e metallo. Il metallo in questione era piombo di provenienza iberica, estratto nelle miniere di Carthago Nova e commercializzato in forma di lingotti da 100 libbre (circa 30 kg), bollati con i nomi dei produttori, quasi tutti di origine campana. Fiduii, Utii e Lucretii apposero i loro gentilizi (nomi di famiglia) sul metallo, permettendo di ricostruire un aspetto significativo di un antico commercio.