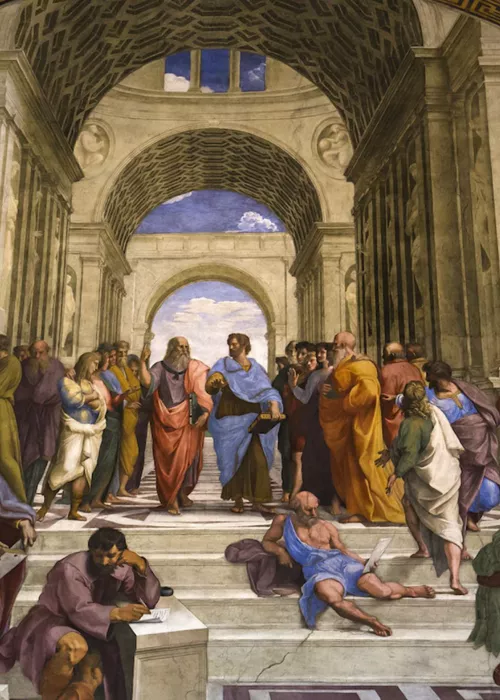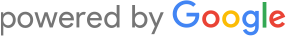I relitti con anfore. Antichi commerci mediterranei
5 minuti

Indice
Sin dalla nascita della moderna archeologia subacquea, le anfore sono apparse come il simbolo stesso dei tesori sommersi e delle scoperte sottomarine, ma anche dei saccheggi più indiscriminati ai danni del patrimonio disperso sui fondali. In una vera e propria caccia al reperto, migliaia di antiche anfore sono finite per anni nei mille rivoli del mercato clandestino, strappate ai loro contesti, vendute come pezzi da collezione, private della possibilità di raccontare le loro storie.
Tutto questo è stato un danno importante per il patrimonio comune se si considera che questi banali contenitori, in fondo semplici vuoti a perdere dell’antichità, hanno di fatto un irrisorio valore commerciale ma un considerevole valore storico: le iscrizioni incise o dipinte sulla loro superficie offrono informazioni su rotte e attori del commercio marittimo; i resti al loro interno permettono di ottenere preziose informazioni sui liquidi contenuti; la stessa argilla utilizzata per fabbricarle racconta le aree di produzione.
Oggi sono ancora numerosi i relitti con carichi di anfore distesi sul fondo del Mediterraneo: navi etrusche, fenicie, greche e romane affondate con migliaia di anfore cariche di olio, vino, salse di pesce o altri prodotti. Per chi ha la fortuna di immergersi su questi siti, l’emozione è garantita: le anfore, ormai colonizzate dalla vita marina, seguono le forme della stiva che le ha contenute, spesso proteggendo gli antichi legni navali dalla corrosione marina.
Rendere visitabili questi siti straordinari ma fragili, garantendo al tempo stesso la loro conservazione, è una delle grandi sfide dell’archeologia subacquea contemporanea, che ha da tempo cessato di recuperare anfore dai fondali, preferendo la loro conservazione in situ. Una scelta che può sembrare curiosa, che si spiega con la necessità di preservare i reperti archeologici nei luoghi e con le condizioni che li hanno protetti per secoli, ma anche con la consapevolezza che un carico di anfore, spesso costituito da centinaia se non migliaia di prodotti seriali, avrebbe un limitato valore espositivo, e finirebbe invece a riempire i già carichi depositi museali.
Il relitto di Capo Mulini. 400 anfore sul fondo del mare di Catania

Alcuni relitti, trovandosi a profondità notevoli, sono scampati ai saccheggi e si presentano in condizioni eccezionali: è il caso, ad esempio, del relitto di Capo Mulini, localizzato nel 2009 nell’area dell’AMP Isole dei Ciclopi e rilevato dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana nel 2016.
A una profondità compresa tra 55 e 70 metri, oltre 400 anfore destinate al trasporto del vino, datate tra il II e il I secolo a.C., sono ancora perfettamente integre, pur se ricoperte di spugne e frequentate da pesci, murene, gronghi e aragoste.
Del relitto che trasportava il prezioso carico, lungo una ventina di metri, si conservano, in ottimo stato, le ancore di prua e, a poppa, le tubazioni per la sentina, lunghe 4 metri.
Nonostante la profondità considerevole, oggi il relitto di Capo Mulini è visitabile affidandosi ai diving centers autorizzati dalla Soprintendenza che, dopo una breve navigazione dinanzi alla costa rocciosa e ai paesaggi verghiani di Aci Trezza conducono i subacquei direttamente sulla verticale del sito, offrendo un’esperienza unica -riservata però ai sub dotati di brevetti tecnici.
Il relitto di Cala Reale. Migliaia di frammenti nell’acqua cristallina dell’Asinara

Nell’area dell’AMP dell’Isola dell’Asinara esiste un relitto che è davvero imperdibile per ogni appassionato di mare e archeologia: si tratta della nave romana di Cala Reale, un vero e proprio cargo che, proveniente dall’occidente iberico, naufragò nel IV secolo d.C. con un imponente carico di anfore di pesce sotto sale e di garum, la famosa salsa ricavata dal pesce e apprezzatissima nei banchetti antichi.
Le antiche anfore sono oggi sparse sul fondale, in un’impressionante distesa composta da quasi 40.000 frammenti. Un vero e proprio giacimento storico, spostato pazientemente di circa 300 metri dal luogo effettivo di rinvenimento, per garantire conservazione e fruizione.
Visitare questa meraviglia dell’archeologia subacquea non è un’impresa ardua: il sito è ad appena 7 metri di profondità, e le acque cristalline della Sardegna settentrionale consentono anche agli apneisti e ai non-subacquei la fruizione del relitto, con l’ausilio del locale Diving Center, autorizzato dalla Soprintendenza.
Il relitto delle Tre Senghe, meraviglia sommersa delle Tremiti

Anche alle Isole Tremiti, lo splendido arcipelago adriatico dinanzi alle coste del Gargano, esiste un relitto carico di anfore davvero degno di nota: è il relitto delle Tre Senghe, una nave romana lunga 20-24 metri e larga 5, affondata a 25 metri di profondità nei pressi della costa Sud dell’isola di San Domino.
A partire dal 1980, quando gli archeologi svolsero il primo sopralluogo sul sito, oltre 150 anfore recuperate dal relitto (che ne conteneva almeno 900, per almeno 45 tonnellate di carico) hanno permesso di ottenere preziose informazioni: la nave dovrebbe aver fatto naufragio tra il 30 e il 20 a.C., ed era destinata al trasporto del vino, organizzato nella stiva su tre livelli. A bordo c’erano anche piccole anforette per il vino più pregiato, oltre a oggetti ceramici e a una piccola spada in ferro e bronzo.
Il relitto delle Tre Senghe, uno dei circa quindici relitti segnalati nell’arcipelago delle Tremiti, è una tappa importante nella storia dell’archeologia subacquea italiana, ma anche un sito prezioso per la ricostruzione dei commerci marittimi di età romana in Adriatico.
Il relitto Plemmyrion B. Anfore dall’Africa, e barre di ferro

In uno dei luoghi più incantevoli della costa siracusana, dove il mare si incunea lungo la penisola del Plemmirio, almeno tre relitti antichi hanno lasciato preziose tracce archeologiche. Tra questi il Plemmyrion B, scoperto a una profondità compresa tra 22 e 47 metri, è caratterizzato dalla presenza di un carico di anfore dei tipi Africana e Mauretana, la cui datazione spazia tra fine del II e la metà del III secolo d.C.
Si tratta di un relitto che ha stimolato non poco la curiosità degli archeologi: le anfore di produzione africana, solitamente destinate al trasporto dell’olio di oliva, prodotto in età romana imperiale in enormi quantità lungo le coste del Nordafrica, sembrano mostrare tracce riconducibili alla presenza di pesce salato.
Accanto alle anfore viaggiava anche del metallo: delle grandi concrezioni ferrose sembrano il prodotto dell’ossidazione di una tonnellata di barre di ferro. La nave del Plemmirio trasportava dunque un carico misto e diversificato, lungo le rotte del commercio redistributivo.