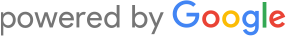Norcia - Cascia

Norcia, antica città sabina poi romana, conserva numerose testimonianze artistiche e storiche legate alla vita di San Benedetto, che nacque qui intorno all’anno 480. La basilica sembra sia stata costruita sui resti della casa natale del santo o, più probabilmente, nello stesso luogo dove sorgeva una basilica di epoca romana. In ogni caso, la costruzione originale risale al XII secolo.
Visitare i luoghi suggestivi e ricchi di storia di questo borgo vuol dire immergesti in un passato che non smette di comunicare al presente. Da non perdere: la chiesa di Santa Scolastica che risale al 580; la Cattedrale di Santa Maria Argentea, costruita su un preesistente tempio pagano dedicato alla Dea Fortuna Argentea; la Rocca della Castellina, e le Marcite, prati perenni resi irrigui dai Benedettini sfruttando le sorgenti a temperatura costante.
Non distante dal centro sono visibili, inoltre, i ruderi della chiesa della Madonna della Neve, edificata su disegni del Bramante.
Il cammino si snoda tra i campi e i boschi dove prendono vita le prelibatezze di una cucina, fatta di legumi, tartufi, olio extravergine e tanti altri prodotti genuini.
Cascia – Monteleone di Spoleto

17,9 km
Cascia è la città di Santa Rita. La sua Rocca e la trecentesca Chiesa di Sant’Agostino, costruita su un oratorio eremitico, testimoniano il suo passato medievale. Sottostante la Rocca, si poggia la Basilica di Santa Rita, cuore della città.
È d’obbligo una visita a Roccaporena, una frazione poco distante da Cascia, e allo Scoglio Sacro dove, come vuole la tradizione, sembra che Rita salisse, attraverso un sentiero scosceso, per pregare e sentirsi più vicina a Dio. Il sentiero, oggi decisamente più praticabile, giunge ad una cappellina costruita nel 1919, che racchiude lo sperone di roccia su cui Rita pregava.
Lasciando Cascia il cammino sale in quota e i campi coltivati lasciano il posto a rigogliosi boschi e estesi pascoli che danno un sapore montano ai numerosi formaggi che si producono ancora artigianalmente.
Monteleone di Spoleto – Leonessa

Il borgo di Monteleone di Spoleto si trova all’interno del Parco Naturale Coscerno-Aspra. Il borgo è, infatti, circondato da un paesaggio selvaggio e rustico. Da visitare la chiesa di San Francesco che conserva, nei sotterranei, opere d’arte davvero importanti: oltre ad una statua lignea di Sant’Antonio Abate, un affresco del primo Quattrocento raffigurante la Madonna del Voto, l’altare barocco dedicato a San Felice. Trova posto nel museo il gioiello di Monteleone. Si tratta di una biga, un carro da parata, prodotto da officine etrusche intorno al 540 a.C. e che oggi è il pezzo più prestigioso della collezione etrusca del Metropolitan Museum di New York. A Monteleone di Spoleto è visibile una copia a grandezza naturale del carro realizzata dalla fonderia di Giacomo Manzù.
Lungo il tragitto che guida verso Leonessa attraversiamo il confine tra Umbria e Lazio e ci fa da guida il Terminillo che, con le sue faggete, da rifugio all’orso marsicano. Nella vallata le fioriture più varie, nutrimento per le api che danno un miele pregiato, sono intervallate dai filari ordinati delle coltivazioni della tipica patata di Leonessa.
Leonessa – Poggio Bustone

Adagiata alle pendici del monte Tilia, Leonessa venne fondata nel 1278 in seguito all’unione di vari castelli preesistenti nella zona. Qui possiamo incontrare alcune testimonianze della sua storia medievale come le due antiche porte d’accesso, la Porta Aquilana risalente al XIII secolo, e Porta Spoletina del XIV secolo. Le porte, insieme alla Torre Angioina e ad alcuni ruderi delle mura di cinta è ciò che rimane dell’originale sistema difensivo del paese. Di antiche origini e rimaneggiata nel XII secolo la Fonte della Ripa era l’unica risorsa idrica di Leonessa. Le sue acque provengono dalla sorgente della Rocca.
Si tratta della tappa più montana di tutto il cammino, sviluppandosi a quote comprese tra i 900 e i 1500 m. Il percorso è quasi interamente all’interno di una estesissima faggeta di importanza storica in quanto al suo interno passava il confine tra Stato della Chiesa e Regno delle due Sicilie.
Poggio Bustone – Rieti

Poggio Bustone, aggrappato a una collina nella parte più verde del Lazio, dall'alto della sua posizione domina la piana di Rieti. È noto per aver dato i natali a Lucio Battisti, per la produzione dell'ottima porchetta locale, ma soprattutto per il santuario di San Francesco. Il convento, fondato nel 1208 proprio dal Santo mostra ancora il suo aspetto medievale. Al fianco al chiostro c’è l'accesso al romitorio che porta nel luogo in cui San Francesco si raccoglieva in preghiera e dal piazzale di fronte al santuario, un sentiero si inerpica sulla montagna e porta fino alla Grotta delle Rivelazioni, dove san Francesco ricevette la visione di un angelo.
In queste due tappe il cammino di San Benedetto interseca i cammini francescani.
Scendendo verso Rieti il paesaggio montano del Terminillo degrada verso la piana ricca di acqua. Dove si possono ammirare campi di girasole e estese coltivazioni del grano “Rieti originario” che arricchisce la cucina locale di ogni tipo di pasta e dolci.
Rieti – Rocca Sinibalda

Circondata in parte dalle possenti mura medievali, Rieti ci accoglie e protegge. Riconosciuta come centro dell’Italia, conserva numerosi monumenti e luoghi d’interesse. La Cattedrale di Santa Maria Assunta è stata eretta tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo e ci affascina con la semplicità dell’esterno realizzato in stile romanico ma anche con le decorazioni barocche dell’interno. Nelle varie cappelle troviamo numerose opere scultoree realizzate da importanti artisti, tra i quali Gian Lorenzo Bernini, e una ricca collezione di meravigliosi dipinti.
Non meno importanti sono la Basilica minore di Sant’Agostino, la Chiesa di San Domenico, la Chiesa di San Francesco, così come imponenti opere civili come il Teatro Flavio Vespasiano, il Palazzo Vescovile, il Palazzo Comunale e numerosi di altri stupendi palazzi.
Se la bellezza va gustata, va gustata fino in fondo: le costruzioni antiche fanno da sfondo ad una affascinante visita nei sotterranei della città.
Lasciata la piana reatina ci incamminiamo lungo la valle del fiume Turano fino a raggiungere Rocca Sinibalda.
Rocca Sinibalda – Castel di Tora

Rocca Sinibalda spicca da lontano con il suo castello, risalente al 1085. Ricostruito come fortezza dall'architetto Baldassarre Peruzzi venne decorato con affreschi che addolcirono lo stile spartano; classificato nel 1928 come monumento nazionale, negli anni Cinquanta divenne proprietà dalla scrittrice americana Caresse Crosby, che lo utilizzò come luogo d'incontro per artisti. L'intero maniero è stato restaurato e riaperto nell'aprile del 2014.
Continuando a risalire la vallata del fiume Turano si arriva all’omonimo lago e da qui, raggiungere Castel di Tora.
Castel di Tora – Orvinio

il borgo di Castel di Tora è adagiato sulle rive del lago artificiale del Turano, circondato da un paesaggio di rara bellezza. Il lago è il fulcro della vita locale: attrazione principale con numerose attività culturali, sportive e turistiche.
Visitare Castel di Tora vuol dire immergersi nel medioevo. I resti del Castello dell’XI secolo, la Chiesa di San Giovanni Evangelista e le stradine ripide disseminate di archi, passaggi e scalinate e grotte.
Questa tappa, piuttosto impegnativa ma straordinaria dal punto di vista paesaggistico, attraversa un paesaggio incontaminato dove i segni di un’agricoltura sofferta ci conducono verso Orvinio. I profumi delle ginestre e del timo, ci accompagnano lungo i crinali dei monti e i secolari castagneti. Attraversato il piccolo borgo di Pozzaglia Sabina, scendendo un crinale ampio e molto ripido ci avviamo verso Orvinio. Lungo la comoda sterrata incontriamo l’affascinante Abbazia di Santa Maria del Piano, quasi completamente diroccata, con il suo bellissimo campanile ancora intatto.
Una ultima salita ci porta ad Orvinio, borgo pittoresco e ricco di storia, che ci accoglie con la fragranza del suo pane appena sfornato.
Orvinio – Mandela

Nella parte alta del borgo la chiesa di Santa Maria dei Raccomandati, edificata nella seconda metà del XVI secolo, custodisce opere dei pittori Ascanio e Vincenzo Manenti che nacquero qui.
Altre opere del Manenti abbelliscono la chiesa di San Giacomo, progettata da Gian Lorenzo Bernini in forma ottagonale e risalente al 1612.
Da Orvinio il percorso attraversa un alto pianoro che scende poi, attraverso la valle Ustica, verso la valle dell’Aniene. Lungo il tragitto incontriamo Percile e Licenza, dove il poeta latino Quinto Orazio Flacco volle costruire la sua splendida villa di campagna. Il cammino passa, in questo punto, all’interno del Parco dei Monti Lucretili con i suoi ambienti incontaminati e la sua ricca fauna. A Civitella di Licenza il Museo dell’Aquila Reale ci permette di conoscere le abitudini dello splendido rapace che nidifica sulle alture del monte Pellecchia.
Mandela – Subiaco

Mandela è un piccolo borgo che affonda le sue origini nel XIII secolo dall’unione dei due nuclei di Cantalupo e Burdella per opera della famiglia Orsini. Molto interessante è la Chiesa di San Vincenzo anche grazie ai monumenti funebri della famiglia Bonaparte e Del Gallo.
Scendendo la strada provinciale che porta alla via Tiburtina, si arriva al Convento di San Cosimato di Vicovaro, un luogo importante per la vita di San Benedetto.
Scendendo le scale davanti l’ingresso della Chiesa, è possibile osservare la particolarità e la bellezza del complesso roccioso: al termine della scalinata scavata nella roccia, si arriva alla cappella rupestre dedicata a San Michele Arcangelo dove avvenne il tentato avvelenamento di San Benedetto; Affreschi del Rosati di fine '600 ne decorano l’interno. Un altro complesso di grotte è raggiungibile dal giardino sul retro del convento: una piccola grotta, che si ritiene fosse la cella di san Benedetto, venne poi trasformata in cappella rupestre. I due complessi rupestri, infatti, seppur non più comunicanti, non hanno perso il loro unicum né visto scalfito minimamente il loro fascino naturalistico e l’intensa carica spirituale e mistica.
Il cammino lascia la vallata dell’Aniene per addentrarsi nella valle del Giovenzano che, con i suoi verdeggianti prati stretti tra due catene di monti, passa per Gerano e, valicando il monte passando per Canterano, riscende nell’alta valle dell’Aniene giungendo a Subiaco.
Subiaco – Trevi nel Lazio

Sublacum (sotto il lago) è il nome che tradisce l’origine di questo borgo, culla del monachesimo benedettino, immerso nel Parco Naturale dei Monti Simbruini. Fu Nerone, infatti che decise di farsi costruire qui una villa dal cui lago prese il nome la cittadina.
Luogo selvaggio e di grande attrazione, alcuni secoli dopo attirò anche il giovane Benedetto che in questo territorio trovò ristoro e fondò ben tredici monasteri.
Poco lontano, il monastero di santa Scolastica: considerato il più antico dei monasteri benedettini, può essere considerato uno scrigno dell’arte e del sapere. Gli edifici che lo compongono spaziano, nelle forme e nella decorazione, tra gli stili più vari: dal campanile romanico al chiostro cosmatesco alla chiesa settecentesca.
Altro primato importante è l’impianto della prima tipografia italiana, ad opera di due chierici tedeschi, nel 1465, che arricchì la già ricchissima biblioteca monastica.
A svettare sul centro storico di Subiaco troviamo la Rocca Abbaziale. Di origine medievale ma largamente trasformata fra i secoli XVI e XVII, vide nascere Lucrezia Borgia. Alle pendici del borgo, cattura il nostro sguardo il medievale ponte di San francesco che conduce alla chiesa omonima del 1327, con altari lignei e pregevoli pitture dei secoli XV e XVI.
Nel Settecento, Subiaco visse un periodo dell’oro: divenne papa, infatti, con il nome di Pio VI, Giovannangelo Braschi, abate commendatario di Subiaco. A lui si deve il fervore artistico che investì la cittadina.
Continuando la risalita della valle dell’Aniene il percorso si addentra sempre più nel parco dei monti Simbruini per giungere a Trevi nel Lazio.
Trevi nel Lazio – Collepardo

Le origini di Trevi nel Lazio si devono all’antico popolo degli Equi che resistette a lungo alla dominazione romana, anche grazie alle possenti mura pelasgiche che ne testimoniano l’ingegno costruttivo e militare.
Visitando questo borgo suggestivo dall’aspetto tipicamente medievale, si possono ammirare alcuni dei tesori artistici e architettonici come la Collegiata di Santa Maria Assunta risalente al 1200.
Interessante anche l’Oratorio di San Pietro costituito da un’unica navata, con volta a botte: la chiesa venne costruita nel 1685, sul luogo dove si riteneva fosse morto il santo patrono del paese. Al suo interno conserva un settecentesco gruppo scultoreo di marmo che raffigura la morte del santo di Trevi.
Una delle testimonianze storiche più importanti di Trevi nel Lazio è il Castello Caetani posto nella parte più alta e più antica del paese.
Continuando il cammino si passa dai Monti Simbruini agli Ernici, attraverso paesi di montagna dove il tempo sembra essersi fermato. La prima parte di percorso è un affascinante sentiero che ripercorre un'antichissima via di comunicazione e possiamo ammirare uno splendido arco romano in mezzo al bosco.
Collepardo – Casamari

Il piccolo borgo di Collepardo è uno dei centri più pittoreschi della Ciociaria.
Il suo territorio, ricco di bellezze artistiche e soprattutto naturalistiche, attira i turisti alla ricerca di paesaggi incontaminati. Già abitato dal popolo degli Ernici, questo territorio aspro e solitario, richiamò a sé diverse comunità di monaci e singoli eremiti che svolsero qui i propri ritiri spirituali.
La chiesa del Santissimo Salvatore, la Chiesa della Consolazione, l’adiacente Chiesa di San Rocco e la Chiesa della Ss. Trinità e, a poca distanza dal centro abitato, è possibile visitare le Grotte dei Bambocci o Grotte della Regina Margherita (in onore della visita della sovrana nel 1904). Lo spettacolo offerto dalle stalattiti e stalagmiti è davvero affascinante.
Riprendendo il nostro Cammino incontriamo la splendida certosa di Trisulti, e da qui, una bella strada di montagna tra splendidi boschi, prati e ampie vedute, verso la valle del fiume Liri, che sarà quella che ci accompagnerà fino alla fine del Cammino. Qui troviamo un autentico gioiello, uno dei rarissimi esempi in Italia di “gotico cistercense”: l’Abbazia di Casamari.
Casamari – Arpino

Vicino al Fiume Amaseno sorge l’imponente Abbazia di Casamari. Fondata dai monaci benedettini nel XI secolo, agli inizi del XIII secolo passò all’Ordine monastico Cistercense che ne rimodernò ed ampliò la struttura. Oggi è, insieme a Fossanova, uno dei più notevoli monumenti di architettura gotico-cistercense rimasti intatti.
Tra le sculture del coro ligneo, si nota la figura di un piccolo cigno intarsiato che s’incide il petto con il becco. Sulla lunetta del Portale dei Conversi è raffigurato l’emblema dell’Albero della Vita affiancato da due croci templari. Una particolarità dell’architettura Cistercense è la quasi assenza di elementi decorativi, finalizzata a non distogliere dalla preghiera il fedele e, nonostante ciò, su uno dei capitelli del chiostro, si trovano riprodotti tre volti raffiguranti Federico II di Svevia, il suo cancelliere Pier delle Vigne, e forse Gioacchino da Fiore, che evidenziano gli stretti rapporti tra l’Imperatore e i monaci Cistercensi.
Da Casamari, per sterrate tra i campi, raggiungiamo Isola del Liri. La piacevole cittadina si sviluppa su un’isola formata dalla potente cascata del fiume. Ripreso il Cammino, poco dopo ci attende la meravigliosa Abbazia di San Domenico, stupendo complesso monastico fondato nel 1011 da san Domenico di Sora sulle rovine della villa natale di Marco Tullio Cicerone. Il percorso prosegue in salita tra ripidi uliveti fino ad Arpino.
Arpino – Roccasecca

Arpino sorge a 450 metri di altezza e accoglie al suo interno importanti palazzi storici e pregevoli chiese. Tra i primi, possiamo citare il Palazzo del Cavalier d’Arpino e il Palazzo Municipale. Notevole è anche il Castello Ladislao, costruito nel 1269 da Ladislao D’Angiò Durazzo, che si presenta ora con le sembianze di un palazzo.
Edificata su un antichissimo tempio pagano, la chiesa di San Michele Arcangelo risale nelle forme al rifacimento del XVIII e XIX secolo. Molto interessante è la chiesa della Madonna di Loreto, caratteristica per la sua pianta a forma ottagonale.
Resti di un lontano passato, le Mura Ciclopiche con la loro maestosità testimoniano la fierezza e l’ingegno delle popolazioni italiche che abitavano questi luoghi.
Tappa molto bella, sotto il profilo storico-artistico e naturalistico il cammino attraversa le gole del Melfa e si incammina in una natura selvaggia e primordiale.
Roccasecca – Montecassino

Dalla sua posizione di vedetta, Roccasecca domina la Valle del Liri e la Valle del Melfa, punto strategico sia per il commercio che per le operazioni militari.
Oltre alla Chiesa di San Tommaso posta proprio sotto il colle dove sorge l’antico abitato, c’è la Chiesa barocca di Santa Maria Assunta, che conserva al suo interno diverse opere di grande pregio. Troviamo, inoltre, la Chiesa e il Convento di San Francesco, il Palazzo Boncompagni e la Chiesa di Santa Margherita anche questa in stile barocco.
Tra i monumenti più importanti non possiamo non menzionare la Chiesa di Santa Maria delle Grazie che conserva un antichissimo affresco proveniente dalla chiesa rupestre di Sant’Angelo e la Chiesa di San Pietro a Campea che sorge sulle rovine di quella che fu la villa di Giovenale, poeta latino nato nella vicina Aquino.
Ad appena un paio di chilometri da Roccasecca s’incontra il piccolo borgo di Caprile, con la chiesa di Santa Maria delle Grazie e l’eremo rupestre di Sant’Angelo in Asprano. Dal sentiero da cui si gode d’una vista mozzafiato sulla valle del Liri, proseguiamo per il grazioso paese di Castrocielo in posizione ancora più elevata sulla valle e ci incamminiamo per l’ultimo tratto di sentiero, quello che ci porterà a Montecassino, tappa anche delle vie Francigene del Sud.
L’abbazia di Montecassino, come la fenice, rinasce sempre dalle sue ceneri
L’Abbazia di Montecassino è uno dei luoghi di culto più importanti del Lazio e d’Italia e può essere definita come la culla del monachesimo occidentale. Fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia, su una zona dove in tempi passati sorgeva un’antica torre e un tempio dedicato ad Apollo. Sorge su una collina a 519 metri d’altezza.
Nel corso della sua storia ha subito numerose distruzioni, saccheggi, terremoti e successive ricostruzioni. Fu proprio San Benedetto a scegliere questa montagna per costruire un monastero che avrebbe ospitato lui e i monaci che lo seguivano da Subiaco.
Benedetto trasformò un luogo sperduto e isolato in un monastero cristiano ben strutturato dove ognuno poteva avere la dignità che meritava, attraverso il lavoro e la preghiera. Nel 577, i Longobardi invasero il complesso benedettino e i monaci furono costretti ad abbandonare l’abbazia portando con loro le spoglie di San Benedetto e rifugiarsi dapprima a Roma, poi presso la comunità di San Colombano. L’abbazia venne distrutta dai Saraceni nel 883 e, soltanto nel 949, venne ricostruita, per volere di papa Agapito II.
Il terremoto del 1349 distrusse nuovamente il complesso monastico che, ricostruito nel 1366, assunse nel XVII secol, l’aspetto tipico del barocco napoletano.
Ben più grave fu la distruzione nella Seconda Guerra Mondiale, ed esattamente il 18 febbraio del 1944: un attacco delle forze alleate rase al suolo l’intera abbazia e, come per miracolo, solo la statua di San Benedetto uscì indenne, rimanendo in piedi fino alla fine.
Per tutto il medioevo, Montecassino fu un fervente centro di cultura grazie alla lungimiranza dei suoi abati e il lavoro dei suoi amanuensi.
Dopo il disastroso bombardamento, tutta la struttura venne ricostruita con un restauro lungo ed accurato ed è considerata un vero simbolo della ricostruzione del dopoguerra italiano.